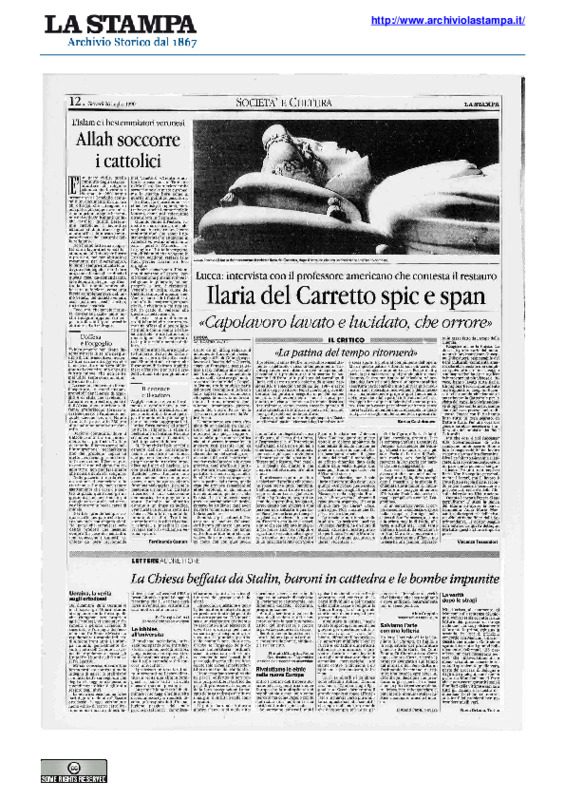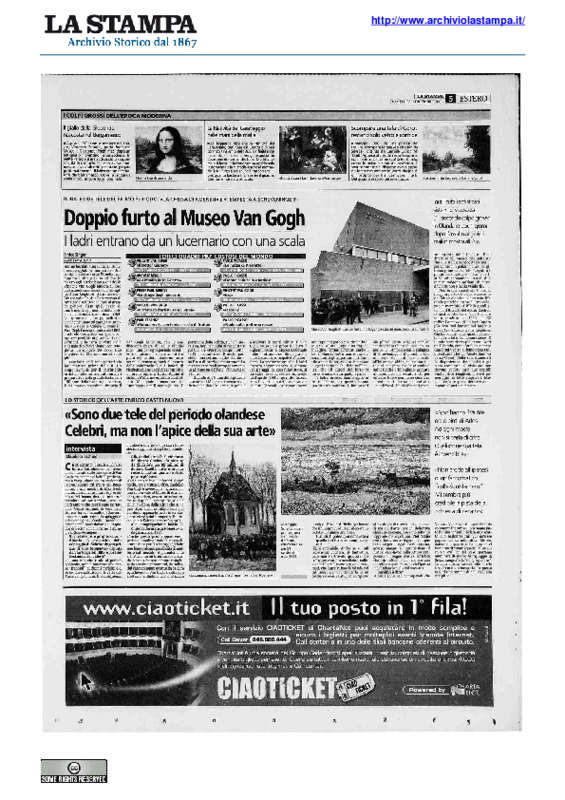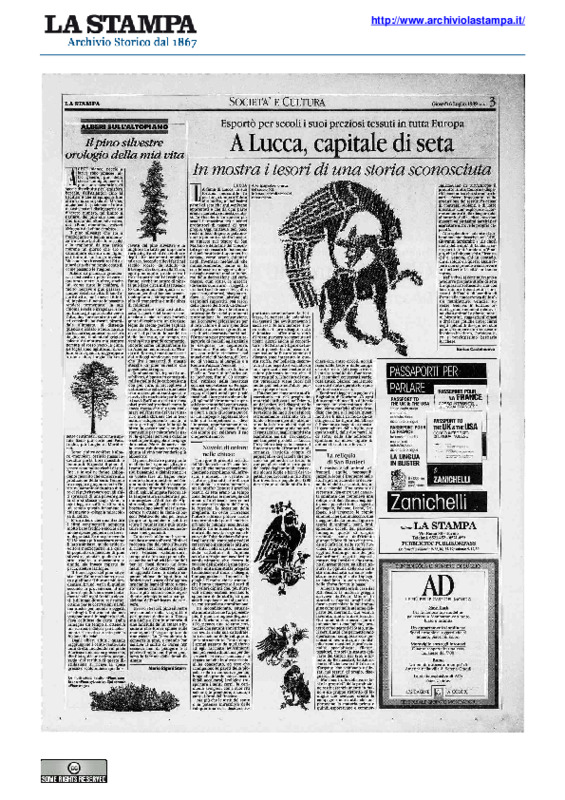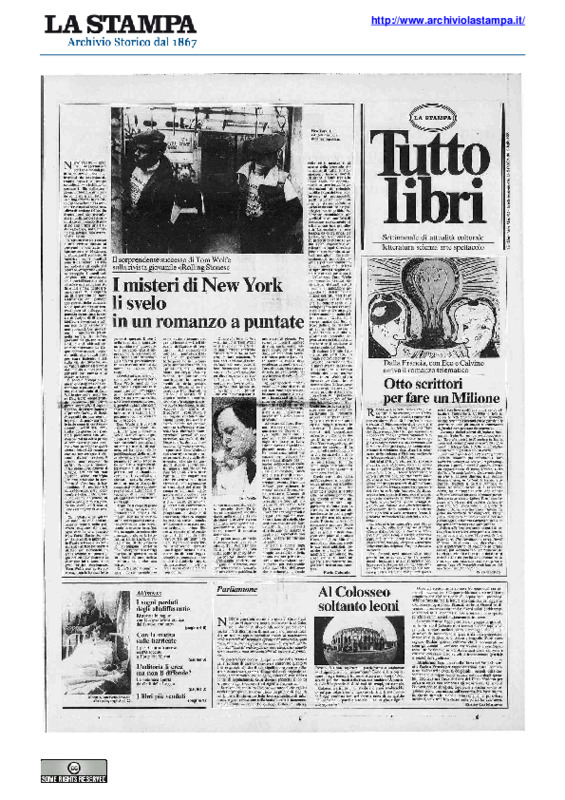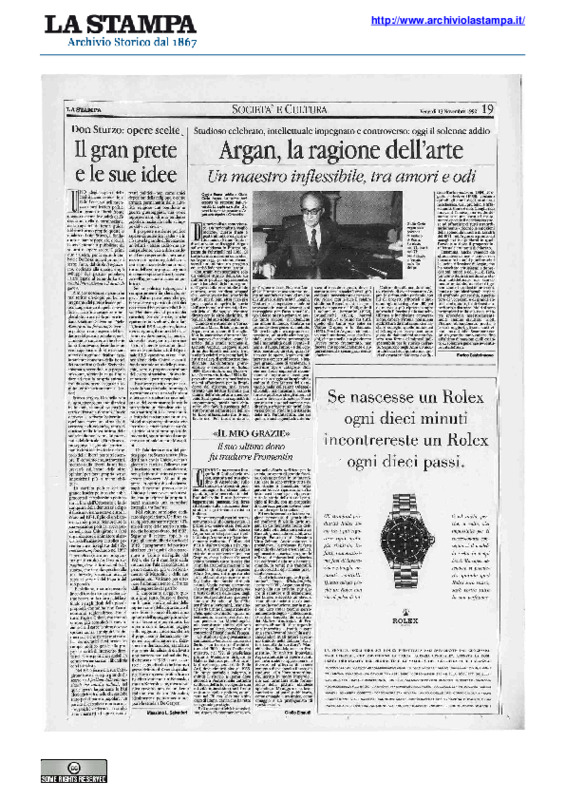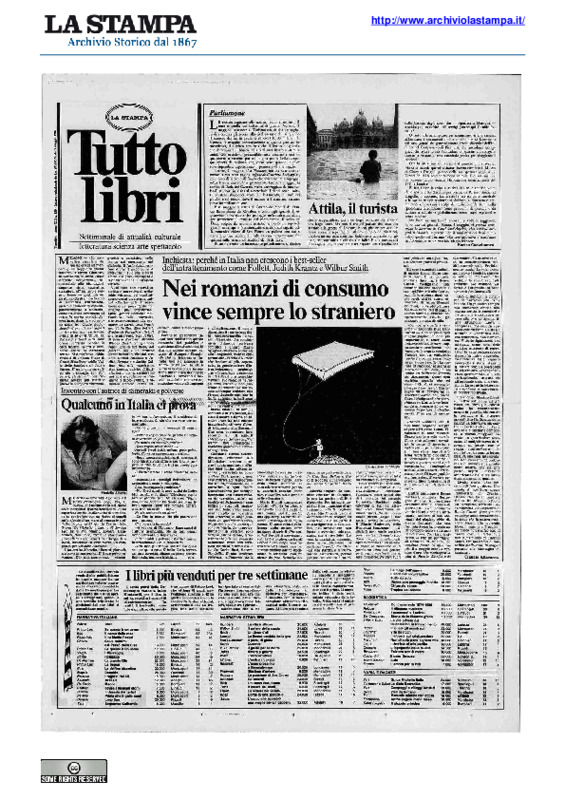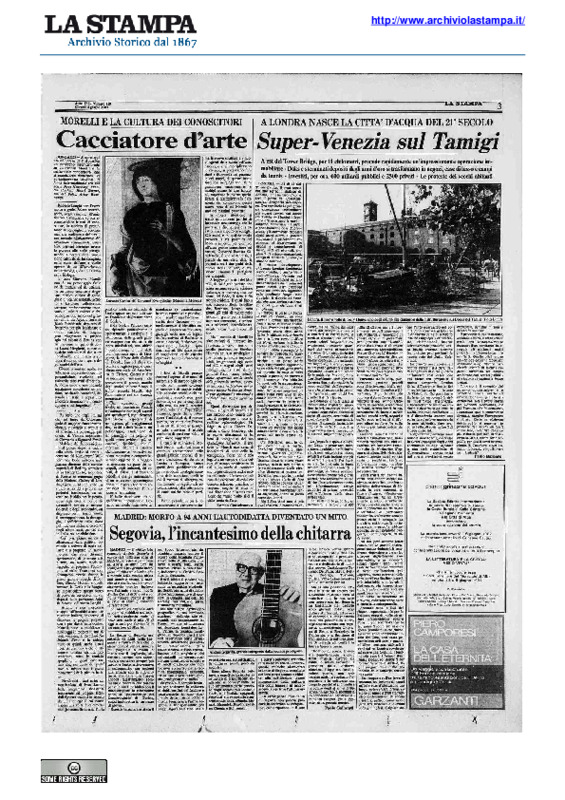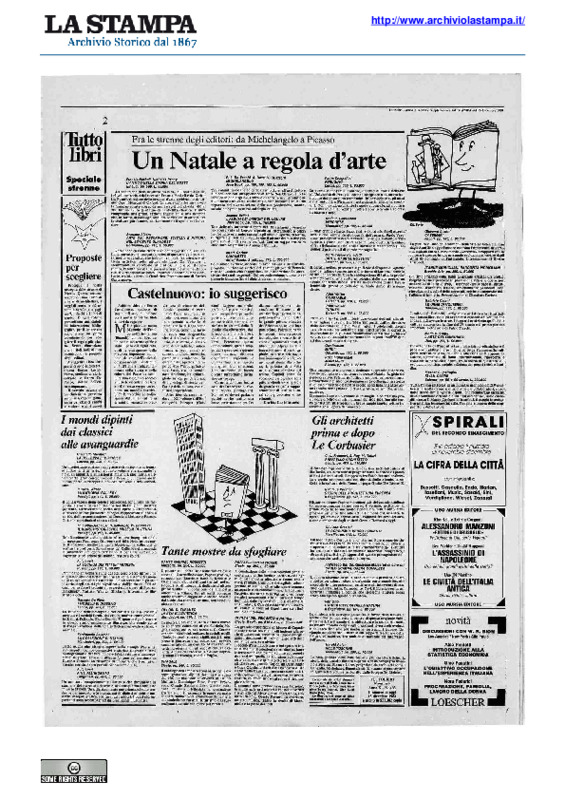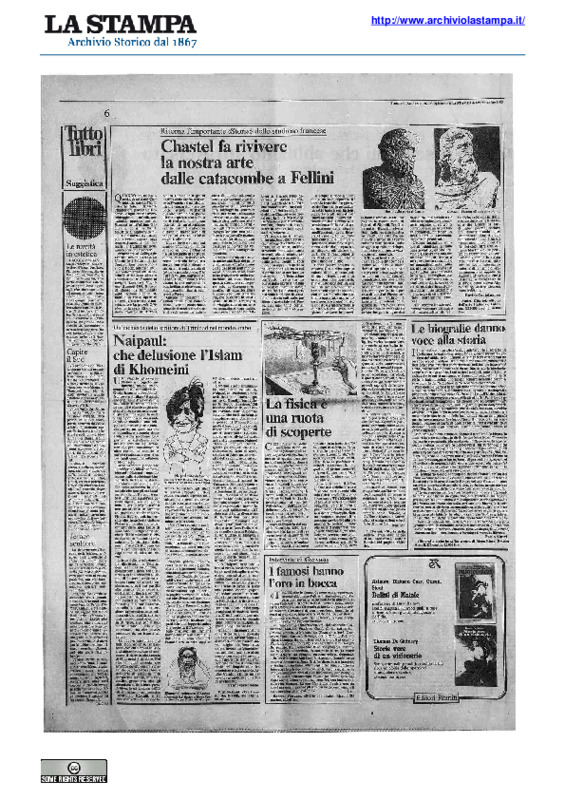Sfoglia documenti (89 in totale)
-
«La patina del tempo ritornerà»
Castelnuovo offre un parere sulla pulitura della tomba di Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia, in margine all’articolo di Vincenzo Tessandori, Ilaria del Carretto spic e span. Il restauro era stato fortemente criticato da James Beck, docente alla Columbia University nonché studioso dello scultore, e dalla stessa cittadinanza, che ritenevano l’intervento troppo invasivo nel rimuovere la “patina del tempo”. Castelnuovo si sofferma sulla differenza tra gli strati di cere e olii stesi dagli stessi scultori per creare determinati effetti, da preservare in quanto parte dell’opera, e la patina che deposita “quel grande pittore che è il tempo”, non prevista in origine e che, anche se rimossa, con gli anni torna a formarsi.
La tomba di Ilaria del Carretto è menzionata in due altri articoli del 1987, quando aveva subito un piccolo danno causato da studenti in gita alla Cattedrale di San Martino (Attila, il turista, Nessun decalogo per l'estate). -
«Sono due tele del periodo olandese. Celebri, ma non l'apice della sua arte»
Claudio Giacchino intervista Enrico Castelnuovo in occasione del furto di due tele del Van Gogh Museum di Amsterdam (La congregazione lascia la chiesa riformata di Noenen, inv. s 416 M/1990; Spiaggia di Scheveningen prima di una tempesta, inv. s 3 V /1962). Castelnuovo contestualizza le opere nel catalogo di Van Gogh e ragiona sul loro valore economico, portando ipotesi sul movente della rapina. Le tele sono state ritrovate nel 2016 a Castellammare di Stabia presso Napoli e riconsegnate al Museo: si era trattato di un furto commissionato dal boss Raffaele Imperiale.
L’intervista accompagna l’articolo di Enrico Singer, Doppio furto al Museo Van Gogh. -
A Lucca, capitale di seta
Recensione della mostra: La seta. Tesori di un'antica arte lucchese. Produzione tessile a Lucca dal XIII al XVII secolo (Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi: 16 giugno-30 settembre 1989), a c. di Donata Devoti, catalogo edito da Maria Pacini Fazzi. Castelnuovo presenta un quadro della produzione e della commercializzazione della seta a Lucca tra XII e XIII secolo, inquadrando la città come un centro di primaria importanza nel Basso Medioevo e sottolineando la preziosità di questi manufatti tessili. Si sofferma sui motivi decorativi, ma soprattutto introduce il lettore ai significati simbolici e alle suggestioni che le stoffe seriche stimolavano nell’immaginario dell’uomo medievale: l’articolo ricorda il monaco Reginaldo di Durham che, nel raccontare la traslazione di alcune reliquie, più che dalla loro santità era ammaliato dalla bellezza dei tessuti che le avvolgevano.
Una copia del catalogo è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d'Ateneo “Arturo Graf”. -
Al Colosseo soltanto leoni
Castelnuovo si interroga sull’utilizzo dei siti storici e archeologici per fini culturali, sollecitato dalla sentenza del pretore di Roma, Alberto Albamonte, del 10 luglio 1985. Nelle motivazioni non solo era precisato che i beni culturali dovessero essere destinati a finalità che non ne pregiudicassero la conservazione e l’integrità, ma era soprattutto sottolineato che non potessero essere concessi per scopi non pertinenti alla loro identità originaria. Diversa è la posizione di Castelnuovo, secondo cui l’attenzione è da rivolgere alla preservazione dei beni culturali e non tanto al loro carattere originario, in quanto non è raro che nel tempo abbiano cambiato più volte destinazione d’uso. Il caso della concessione della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia per spettacoli teatrali, citato nell’articolo, è richiamato non tanto per i contenuti ma per i rischi che l’affollamento comporta all’edificio.
Castelnuovo prende le mosse dalla pagina che «L’Unità» dedica alla questione l’11 luglio 1985 (p. 17): il soprintendente ai Beni archeologici di Roma, Adriano La Regina, era stato accusato di abuso di potere e omissione di atti d'ufficio per avere autorizzato una rassegna cinematografica al Circo Massimo e una mostra sull’economia italiana nel Ventennio al Colosseo. Nonostante l’assoluzione, nelle motivazioni del pronunciamento il pretore – poggiando sul parere di una commissione composta da Lorenzo Quilici, Italo Insolera, Vincenzo Cabianca e Giulio Tamburini – criticava apertamente la concessione dei due siti archeologici, ritenendo le manifestazioni non compatibili con “il carattere espressivo del monumento, quale testimonianza storica e quale valore culturale [...]”. -
Argan, la ragione dell'arte
Necrologio di Giulio Carlo Argan (Torino, 17 maggio 1909-Roma, 12 novembre 1992). Per tracciare un profilo intellettuale del collega scomparso, Castelnuovo richiama gli approcci diametralmente opposti alla storia dell’arte del proprio maestro Roberto Longhi e di Lionello Venturi, con cui Argan si formò all'Università di Torino. Se il metodo di Longhi si fondava sul predominio dell'occhio e su un rapporto diretto con l’opera d’arte, all’opposto, “Argan era più portato a concettualizzare, a leggere grandi linee di tendenza, a costruire tipi e categorie. [...] insomma, erano le foreste piuttosto che gli alberi ad attirare la sua attenzione”. La migliore eredità che Argan lasciava alla storia dell’arte era proprio l’impegno a farla uscire dal suo isolamento, per dialogare con le altre discipline.
Castelnuovo menziona quelle pubblicazioni di Argan che più lo hanno colpito: di alcune è presente una copia nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d'Ateneo “Arturo Graf”.- L'architettura protocristiana preromanica e romanica, Firenze, Novissima enciclopedia monografica illustrata, 1936;
- L'architettura italiana del Duecento e Trecento, Firenze, Novissima enciclopedia monografica illustrata, 1937;
- The Architecture of Brunelleschi and the Origins of Perspective Theory in the Fifteenth Century, Journal of the Warburg and Courtault institutes, vol. IX, 1946, pp. 96-121;
- Walter Gropius e la Bauhaus, Torino, Einaudi, 1951
- Borromini, a c. Giulio Carlo Argan, Milano, Mondadori, 1952;
- Brunelleschi, a c. di Giulio Carlo Argan, Milano, Mondadori, 1955;
- Marcel Breuer. Disegno industriale e architettura, Milano, Gorlich, 1957;
- Salvezza e caduta nell'arte moderna. Studi e note II, Milano, Il Saggiatore, 1964 (II ed. 1968);
- Progetto e destino, Milano, Il Saggiatore, 1965 (II ed. 1968).
-
Attila, il turista
Castelnuovo interviene sulla tutela del patrimonio culturale, spronato dai quotidiani nazionali che con grande enfasi avevano ripetutamente denunciato nei primi giorni di maggio il problema del turismo di massa (a Venezia e Firenze) e i danni arrecati dai vandali ai monumenti. Come suggerisce il titolo, l’intervento ribadisce l’urgenza di ragionamenti ben più ampi sulla salvaguardia dei beni culturali, capaci di individuare e affrontare i fattori di rischio (ad esempio l’inquinamento atmosferico delle città che ogni giorno attacca silenziosamente le superfici lapidee).
L’articolo richiama questioni affrontate in altri contributi, come la soluzione di creare delle copie per tutelare i siti più visitati: Castelnuovo aveva già presentato la soluzione della Grotta di Lascaux e della Camera degli Sposi di Mantova, ricostruita a Londra per l’esposizione Splendours of the Gonzaga (nel 1981 aveva recensito la mostra: Fuochi d’artificio dei Gonzaga a Londra; si vedano inoltre: Contro feticci e miti dei capolavori d’arte; Non disturbiamo i bisonti di Altamira). -
Cacciatore d'arte
In occasione dell’apertura del convegno Giovanni Morelli e la cultura dei conoscitori (Bergamo, ex chiesa di Sant'Agostino, 4-7 giugno 1987) e della mostra Giovanni Morelli da collezionista a conoscitore (4 giugno-31 luglio 1987) Castelnuovo tratteggia un profilo del protagonista e del suo metodo d’indagine applicato al riconoscimento delle opere d’arte.
La relazione introduttiva del convegno è tenuta dallo stesso Castelnuovo ed è raccolta nel primo volume degli atti: una copia dell'opera è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d'Ateneo “Arturo Graf”. -
Castelnuovo: io suggerisco
Consigli di lettura per le prossime festività natalizie: nel trafiletto, parte di una pagina dedicata alle strenne natalizie, sono presentati- L'uso dei classici, parte di Memoria dell'antico nell'arte italiana, a c. di Salvatore Settis, Torino, Einaudi, vol. I;
- Bibliografia, repertorio, statistiche, parte dell'Enciclopedia Europea, Milano, Garzanti, vol. XII;
- Svetlana Alpers, Arte del descrivere. Scienza e pittura nel Seicento olandese, Torino, Bollati Boringhieri.
Insieme a Luciano Berti, Pierluigi De Vecchi e Mauro Natale, Castelnuovo aveva elaborato il piano editoriale della sezione storico-artistica dell’Enciclopedia europea, edita da Garzanti tra 1976 e 1984. Del volume di Alpers, aveva scritto la prefazione all’edizione italiana: una copia dell’opera è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. Tutte le opere menzionate nell’articolo sono edite nel 1984.
-
Cattedrale d'orgoglio
L’articolo presenta il Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, in occasione dell’apertura nel 1986: l’elenco delle più significative opere qui raccolte concede a Castelnuovo di rievocare le vicende degli stessi monumenti della Piazza dei Miracoli da cui provengono. -
Chastel fa rivivere la nostra arte dalle catacombe a Fellini
Recensione dell'opera: André Chastel, Storia dell'arte italiana, Roma-Bari, Laterza, 1983 (I ed. L'art italien, Parigi, Larousse, 1956, 2 voll.). L’articolo introduce il volume richiamando il giudizio positivo di Roberto Longhi, promotore della prima edizione italiana tradotta da Anna Banti per Sansoni nel 1957. Castelnuovo rileva che Chastel, pur adottando un’impostazione cronologica di fondo, dimostra una spiccata attenzione per i problemi della geografia artistica e che i ricchi apparati di corredo del testo – le illustrazioni, la bibliografia, l’indice topografico e la lista dei principali musei e monumenti d’Italia, non tutti presenti nell’edizione italiana – rendono l’opera uno strumento da consultare in modo dinamico, al pari di una guida. Il richiamo va al Cicerone di Jacob Burckhardt, già evocato come modello dall’autore stesso nella prefazione alla seconda edizione francese del 1982.
È significativo che il profilo intellettuale di Chastel che emerge nell’articolo pone in risalto l’attività di critico d’arte per il quotidiano Le Monde e gli riconosce, oltre all’approfondita conoscenza dell’arte italiana, uno spiccato talento nella scrittura giornalistica.
Le riproduzioni di opere di artisti piemontesi tra fine Settecento e inizio Ottocento presenti nell'opera sono occasione per richiamare la mostra Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna, 1773-1861, curata dallo stesso Castelnuovo con Marco Rosci (Torino, maggio-luglio 1980).
Nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”, sono presenti, oltre all’edizione Laterza recensita in questo articolo, la seconda edizione francese da cui deriva (L'art italien, Parigi, Flammarion, 1982) e la seconda edizione Sansoni (L’Arte italiana, Firenze, Sansoni, 1957, 2 voll., II ed. 1962).